Mercoledì 14 agosto 2019
di Stefano Testa
Abbiamo il piacere di ospitare sul Blog un articolo di Stefano Testa – avvocato con l’hobby del giornalismo, come lui stesso si definisce -, conosciuto attraverso complicati giri epistolari via mail e le collaborazioni intercorse tra Latina Oggi e Ponzaracconta.
L’argomento è dei più ghiotti, per un cinefilo.
Buona lettura
S. R.
Il 13 agosto del 1899, e dunque 120 anni fa, nasceva a Leytonstone, un quartiere dell’East End di Londra, Alfred Hitchcock, unanimemente considerato uno dei personaggi più importanti della storia del cinema. Per tutti coloro i quali volessero approfondire la figura e l’opera del grande regista britannico, invito vivamente alla lettura di uno splendido volume edito in Italia da Il Saggiatore, ed intitolato “Il cinema secondo Hitchcock”.

Si tratta di una lunga intervista (di oltre cinquecento domande), realizzata nel corso di diversi anni da un altro grande maestro del cinema mondiale, e precisamente da François Truffaut, con l’obiettivo di svelare al pubblico i segreti di «un uomo incredibile e di un regista straordinario».
Il famoso regista francese, nella prefazione del libro, spiega le motivazioni che lo indussero a realizzare questo insolito “progetto giornalistico”: egli voleva rendere giustizia al collega inglese il quale, nonostante i numerosi successi che avevano costellato la sua lunga carriera, non era tuttavia adeguatamente stimato dalla critica cinematografica americana. Ed infatti, in proposito, così scrive: «Non si tratta di ammirare estaticamente l’opera di Alfred Hitchcock, né di definirla perfetta, ineccepibile e senza alcuna imperfezione. Penso soltanto che la sua opera sia stata finora così gravemente sottovalutata che è importante prima di tutto darle il suo giusto posto tra i primissimi… anche i suoi denigratori sono d’accordo nell’assegnargli il titolo di primo tecnico del mondo… come l’hanno ben definito Eric Rohmer e Claude Chabrol, Alfred Hitchcock non è né un narratore di storie né un esteta, ma “uno dei più grandi inventori di forme di tutta la storia del cinema. Solo, forse, Murnau ed Eizenstejn possono, su questo argomento, sostenere il paragone con lui… la forma qui non abbellisce il contenuto, lo crea”.
Il cinema è un’arte particolarmente difficile da dominare per la molteplicità delle doti – a volte contraddittorie – che esige. Se tante persone molto intelligenti o molto creative hanno fallito nella regia, la ragione è che lo spirito di analisi e lo spirito di sintesi che, tenuti simultaneamente all’erta, permettono di eludere le innumerevoli trappole create dalle frammentazioni del decoupage delle riprese e del montaggio dei film… ogni inquadratura è un’informazione che si dà al pubblico…

Hitchcock ha scelto di esprimere tutto visivamente… si trova ad essere prati-camente l’unico a filmare direttamente, cioè senza ricorrere al dialogo esplicativo dei sentimenti come il sospetto, la gelosia, il desiderio, l’invidia… è il solo cineasta in grado di filmare e renderci percettibili pensieri di uno o più personaggi senza ricorrere al dialogo, il che mi autorizza a vedere in lui un regista realista… lo stile di Hitchcock si riconosce anche in una scena di conversazione tra due personaggi, semplicemente dalla qualità drammatica dell’inquadratura, dal modo realmente unico di distribuire gli sguardi, di semplificare i gesti, di ripartire i silenzi nel corso del dialogo, dall’arte di creare nel pubblico la sensazione che uno dei due personaggi domina l’altro, quello di suggerire, al di fuori del dialogo, tutta un’atmosfera drammatica precisa, l’arte infine di condurci da un’emozione all’altra, seguendo la sua sensibilità… il cinema di Hitchcock non sempre è esaltante, ma arricchisce sempre, se non altro per la grandissima lucidità con la quale denuncia le offese fatte dagli uomini alla bellezza e alla purezza.
Se siamo disposti ad accettare l’idea che il cinema non sia inferiore alla letteratura credo che sia necessario classificare Hitchcock nella categoria degli artisti inquieti, come Kafka, Dostoevskij, Poe. Questi artisti dell’angoscia non possono evidentemente aiutarci a vivere, perché vivere per loro è già difficile, ma la loro missione è di dividere con noi le loro ossessioni. Con questo, ed anche eventualmente senza volerlo, ci aiutano a conoscerci meglio, il che costituisce un obiettivo fondamentale di ogni opera d’arte».
La prima cosa che si percepisce, leggendo il libro di Truffaut, è la “complicità professionale” che esiste tra i due grandi registi (i quali, conversando degli oltre cinquanta film girati da Hitchcock durante la sua carriera, offrono al lettore una visione molto tecnica delle sceneggiature, delle riprese, della recitazione, e degli aspetti produttivi). Tuttavia, tra di loro, sembra esistere un inspiegabile distacco. Evidenziato ad esempio dal fatto che si rivolgono, l’uno all’altro, attraverso un formalissimo “lei” che appare francamente ingiustificato, viste le circostanze.
La lunga intervista si apre richiamando un episodio assai curioso dell’infanzia di Hitchcock, il quale così lo ricorda: «Avevo forse quattro o cinque anni… mio padre mi mandò al commissariato di polizia con una lettera. Il commissario la lesse e mi richiuse in una cella per cinque o dieci minuti, dicendomi: “Ecco cosa si fa ai bambini cattivi”. Non ho la minima idea di cosa avessi fatto per meritare quella punizione».
Tale episodio condizionò notevolmente il grande regista inglese, il quale, infatti, confessò pubblicamente in più occasioni la sua fobia nei confronti della polizia. Elemento, questo, che spesso emerge in molti dei suoi film («Ho sempre provato, come se fossi io la vittima, le emozioni di una persona che è arrestata, viene portata al commissariato in macchina, guarda attraverso le sbarre la gente che entra in un teatro, che esce da un caffè, che fa insomma la vita di tutti i giorni con piacere»).
Ma la giovinezza di Alfred fu comunque piuttosto particolare anche per altri motivi: «Ero quello che comunemente si dice un bambino giudizioso… tutto meno che espansivo. Anche molto solitario. Non ricordo di aver mai avuto un compagno di giochi. Mi divertivo tutto solo e li inventavo io stesso. Sono stato in collegio dai Gesuiti. La mia famiglia era cattolica, cosa che in Inghilterra rappresenta quasi un’eccentricità.
Probabilmente è stato in questo periodo che il sentimento della paura si è sviluppato con forza dentro di me. Paura morale, di essere associato a tutto ciò che è male. Me ne sono sempre tenuto lontano».
Hitchcock rivela a Truffaut anche in che modo si avvicinò alla settima arte: «Andavo molto spesso a teatro… spesso uscivo da solo per andare a vedere le prime, tuttavia il cinema mi attraeva di più, e preferivo i film americani a quelli inglesi», e quando, da semplice “addetto ai sottotitoli” dei film muti, divenne dapprima sceneggiatore, e poi regista. Un giorno, i produttori della casa cinematografica dove lavoravo, mentre conversavano dei loro progetti futuri, dissero: «Ora ci occorre una sceneggiatura.
Mi feci avanti. E confessai: Mi piacerebbe scriverla. Lei?, risposero. Che altre sceneggiature ha fatto? Feci vedere loro l’adattamento di una storia che avevo scritto per esercizio. Rimasero favorevolmente impressionati, e così riuscii ad ottenere il lavoro. Questo accadeva nel 1922… nel 1925, invece, Michael Balcon mi propose di dirigere un film. Gli risposi che non ci avevo ancora pensato perché ero molto contento di scrivere sceneggiature e di fare lo scenografo, e non mi immaginavo assolutamente regista. Ma accettai».
Da qui cominciò una carriera lunghissima, che consacrerà Alfred Hitchcock come uno dei più importanti personaggi della storia cinematografica mondiale. Non tutti sanno che il suo primo film, il regista britannico, lo filmò (in parte) in Italia. Prima a Genova (dove in albergo subì il furto di diecimila lire…) e poi sulle sponde del lago di Como. Già dopo le prime pellicole una parte della critica intuì le potenzialità del novello cineasta, che infatti venne definito dalla stampa specializzata «un giovane con l’intelligenza di un maestro». Ed in effetti, tra le altre cose, egli seppe gestire meglio di tanti altri suoi colleghi dell’epoca il traumatico passaggio dell’arte cinematografica dalla fase del muto a quella del sonoro. E ciò nonostante ritenesse in cuor suo che i film muti fossero «la forma più pura del cinema » e che con l’avvento del sonoro il cinema si fosse «bruscamente irrigidito in una forma teatrale».
La lettura della lunga intervista di Truffaut ci offre la ghiotta occasione di conoscere la metodologia di lavoro di Hitchcock («Leggo una storia solo una volta. Se mi piace l’idea di base la faccio mia, dimentico completamente il libro e faccio del cinema… quello che non riesco a capire è che uno si impadronisca completamente di un’opera, un buon romanzo che l’autore ha impiegato tre o quattro anni per scrivere e che è tutta la sua vita. Prendono il libro, lo manipolano per bene, si circondano di artigiani e tecnici quotati e si ritrovano candidati all’Oscar, mentre l’autore si dissolve sullo sfondo. Nessuno pensa a lui. Se prende un romanzo di Dostoevskij, non solo “Delitto e Castigo”, ma un altro qualsiasi, ci trova molte parole e tutte hanno una funzione precisa… per esprimere la stessa cosa in un modo cinematografico bisognerebbe sostituire le parole con il linguaggio della macchina da presa, girare un film di sei ore o di dieci ore, altrimenti non sarebbe serio… occorre molto mestiere e capacità per riuscire ad ottenere un buon controllo sul tempo… Sono convinto che le sequenze di un film non devono mai procedere con lentezza, ma sempre in modo che l’azione si sviluppi, proprio come un treno “a cremagliera” che sale la ferrovia di montagna, tacca per tacca. Non bisognerebbe mai paragonare un film a un lavoro teatrale o a un romanzo. Quello che più gli si avvicina è il racconto, che si fonda sulla regola generale di contenere una sola idea che arriva ad esprimersi nel momento in cui l’azione raggiunge il punto drammatico culminante. Avrà notato che raramente lo sviluppo di un racconto incontra punti morti, ed è qui che sta la sua somiglianza con il film»).
Leggendo il libro si scoprono anche dettagli e segreti della personalità del grande regista inglese («Quando affronto le questioni di sesso sullo schermo, non dimentico che, anche per tale aspetto, la suspence comanda tutto. Se il sesso è troppo evidente, non c’è più suspence. Perché scelgo delle attrici bionde e sofisticate? Bisogna cercare delle donne di mondo, delle vere signore che diventano delle puttane quando sono in camera da letto. La povera Marilyn Monroe aveva il sesso stampato su ogni angolo del viso, come Brigitte Bardot, e questo non è molto fine… credo che le donne più interessanti, sessualmente parlando, siano le donne inglesi. Credo che loro, le svedesi, le tedesche del nord e le scandinave, siano più interessanti delle latine, le italiane e le francesi. Il sesso non deve farsi notare. Una ragazza inglese, con la sua aria da maestrina, è capace di salire su un taxi con lei – Truffaut, ndr – e, con sua grande sorpresa, di aprirle i pantaloni»).
Dall’intervista si viene anche a sapere l’origine e la motivazione delle famose apparizioni del regista all’interno delle sue pellicole. Hitchcock rivela infatti che, mentre stava girando il film “The lodger”, nel 1926, aveva bisogno di riempire adeguatamente una scena. Ed allora decise di farsi riprendere mentre era seduto ad una scrivania nella redazione di un giornale («più tardi è diventata una superstizione, e infine si è trasformata in una vera e propria gag»).
Truffaut, nella parte finale del suo bel libro, ci svela altri dettagli della vita e dell’opera del grande regista britannico: «Hitchcock era un uomo speciale per il suo fisico, il suo spirito, la sua morale, le sue ossessioni… era un nevrotico il quale, quando da adolescente si rese conto che il suo fisico lo metteva in disparte, si è ritirato dal mondo e l’ha guardato con una severità inaudita… praticando il cinema come una religione… prima della sua morte ebbi l’occasione di incontrare un vecchio padre gesuita che era stato suo compagno al collegio Sant’Ignazio a Londra all’inizio del secolo. Si ricordava molto bene dello scolaro Alfred Hitchcock, tutto rotondo, che si teneva in disparte nel cortile durante la ricreazione. Appoggiato contro un muro guardava i suoi compagni giocare a pallone con un’aria di disprezzo, tenendo già allora le mani incrociate sul ventre… era un uomo le cui paure lo hanno spinto a raccontare le storie più terrificanti. Si è sposato vergine a venticinque anni, e non ha mai conosciuto altra donna che sua moglie… solo quest’uomo poteva riuscire a mostrare l’assassinio e l’adulterio come scandali, egli solo sapeva farlo, ed era il solo che aveva il diritto di farlo».
Tale descrizione ci aiuta a comprendere meglio la personalità del geniale cineasta inglese, ad intuire le sue nascoste fobie, ad interpretare meglio le memorabili immagini dei suoi film. E se è pur vero che David Selznick (il produttore di “Via col vento”), una volta, in una lettera inviata alla moglie, scrisse: «Finalmente ho incontrato Hitchcock. L’uomo è piuttosto simpatico, ma non è il tipo di persona che si può portare in campeggio», è anche vero che la bonaria ed ingombrante figura del regista britannico da sempre suscita, in tutti noi, più simpatia che avversione o terrore. A rendercelo amabile è la sua ironia latente, il suo humor inconfondibile. Che usava spesso, e che gli faceva dire –a mio avviso a ragione – che «i giochi di parole sono la forma più alta di letteratura».
Grazie, Sir Alfred, per avermi incuriosito con “La finestra sul cortile”; per avermi coinvolto con “Intrigo internazionale”, e, perché no, anche per avermi spaventato con “Psyco”.
La penso anche io come François Truffaut: «Hitchcock non si è accontentato di praticare un’arte, ma si è impegnato ad approfondirla, a coglierne le leggi, più strette di quelle che governano il romanzo. Non solo ha reso più intensa la vita, ha reso più intenso il cinema».
François Truffaut Il cinema secondo Hitchcock. Il Saggiatore, 2014


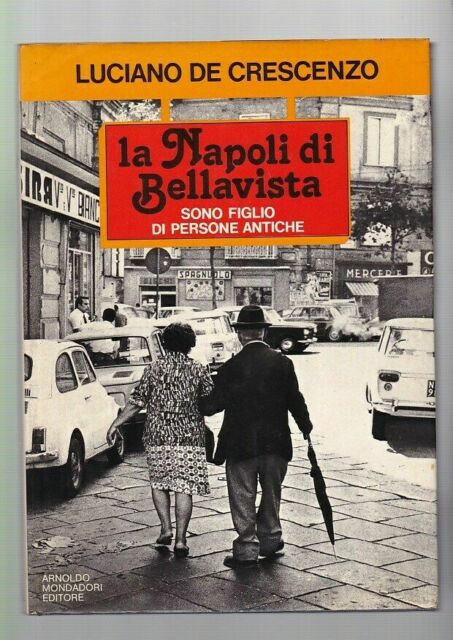


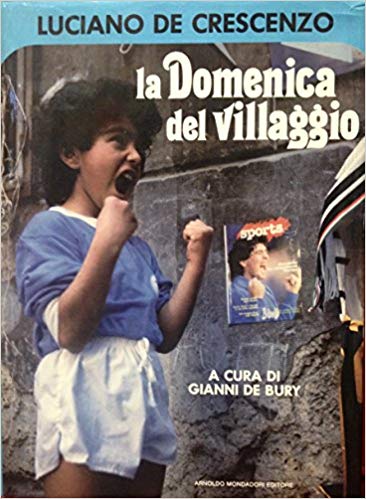




















 Carlo Verdone, ospite della prima puntata di Maledetti Amici Miei, di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, in onda su Rai2 ha assistito, tra il divertito e il preoccupato, all’accorato sfogo di Alessandro Haber, unico tra i presenti a non aver mai lavorato col regista romano: “Hai lavorato con Papaleo, Rubini, Veronesi, Tortora, grandi attori, piccoli attori, cani, porci con me niente.. un caz..sei una merd….”. Verdone che, ridendo, ha infine replicato “Ma tu sei attore di teatro…hai l’impostazione teatrale”.
Carlo Verdone, ospite della prima puntata di Maledetti Amici Miei, di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, in onda su Rai2 ha assistito, tra il divertito e il preoccupato, all’accorato sfogo di Alessandro Haber, unico tra i presenti a non aver mai lavorato col regista romano: “Hai lavorato con Papaleo, Rubini, Veronesi, Tortora, grandi attori, piccoli attori, cani, porci con me niente.. un caz..sei una merd….”. Verdone che, ridendo, ha infine replicato “Ma tu sei attore di teatro…hai l’impostazione teatrale”.



 Ti piace il cinema e vuoi scoprire i suoi segreti? Ti proponiamo un corso attraverso la storia e il linguaggio della settima arte, per scoprire insieme i segreti dei grandi registi e dei film di cui siamo innamorati. Perché la forza di un film non è soltanto la storia che racconta, ma sta nelle immagini con cui questa prende corpo sullo schermo. Analizzeremo e confronteremo il modo in cui grandi registi di ieri e di oggi, come Pedro Almodovar, Quentin Tarantino o Stanley Kubrick, girano un bacio, una sparatoria, un inseguimento e scopriremo che lo stile, quando parliamo di cinema, diventa sostanza e fa la differenza. Il corso si rivolge soprattutto al giovane pubblico del cinema e, in particolare, agli studenti liceali ed intende proporsi come una introduzione al cinema e al linguaggio audiovisivo.
Ti piace il cinema e vuoi scoprire i suoi segreti? Ti proponiamo un corso attraverso la storia e il linguaggio della settima arte, per scoprire insieme i segreti dei grandi registi e dei film di cui siamo innamorati. Perché la forza di un film non è soltanto la storia che racconta, ma sta nelle immagini con cui questa prende corpo sullo schermo. Analizzeremo e confronteremo il modo in cui grandi registi di ieri e di oggi, come Pedro Almodovar, Quentin Tarantino o Stanley Kubrick, girano un bacio, una sparatoria, un inseguimento e scopriremo che lo stile, quando parliamo di cinema, diventa sostanza e fa la differenza. Il corso si rivolge soprattutto al giovane pubblico del cinema e, in particolare, agli studenti liceali ed intende proporsi come una introduzione al cinema e al linguaggio audiovisivo.
 in collaborazione con il Far East Film Festival 21 (Udine, 26 aprile – 4 maggio 2019), tra i più prestigiosi festival di cinema asiatico nel mondo, l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma presenta una selezione di cinque film giapponesi in concorso e fuori concorso nel capoluogo friulano, tutti di recentissima uscita in Giappone, tra cui titoli che al Festival figurano come prime visioni italiane, europee e mondiali.
in collaborazione con il Far East Film Festival 21 (Udine, 26 aprile – 4 maggio 2019), tra i più prestigiosi festival di cinema asiatico nel mondo, l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma presenta una selezione di cinque film giapponesi in concorso e fuori concorso nel capoluogo friulano, tutti di recentissima uscita in Giappone, tra cui titoli che al Festival figurano come prime visioni italiane, europee e mondiali. Due volte l’anno, in prima vera e in autunno , ai tempi di ‘Visioni’ , si andava in “trasferta di cinema” in campagna, al casale di Sandro – zona Castelli Romani località Lanuvio – per i Lanuvio Days. Dopo una pausa, riprendiamo la consuetudine . Al ridente risveglio della natura o ai crepuscolari toni ottobrini, trasferiamo le nostre carabattole, computer, videoproiettore e dvd nel capiente salone del Casale, nella disposizione d’animo adatta alla delibazione di raffinatezze cinefile e gastronomiche. Si tratta di una ‘full day immersion” preferibilmente tematica, con proiezioni in tarda mattinata, pomeridiana e serale. Gli intervalli sono densi di chiacchiere, libagioni e puntate all’esterno, tra i campi, per gli amanti della natura…
Due volte l’anno, in prima vera e in autunno , ai tempi di ‘Visioni’ , si andava in “trasferta di cinema” in campagna, al casale di Sandro – zona Castelli Romani località Lanuvio – per i Lanuvio Days. Dopo una pausa, riprendiamo la consuetudine . Al ridente risveglio della natura o ai crepuscolari toni ottobrini, trasferiamo le nostre carabattole, computer, videoproiettore e dvd nel capiente salone del Casale, nella disposizione d’animo adatta alla delibazione di raffinatezze cinefile e gastronomiche. Si tratta di una ‘full day immersion” preferibilmente tematica, con proiezioni in tarda mattinata, pomeridiana e serale. Gli intervalli sono densi di chiacchiere, libagioni e puntate all’esterno, tra i campi, per gli amanti della natura…



 Il 23-24 marzo 2019 si terrà un Workshop sul Documentario presso la Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi.
Il 23-24 marzo 2019 si terrà un Workshop sul Documentario presso la Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi. Il 15 marzo avrà inizio il Corso di cinema: Visioni urbane: Roma, presso la Libreria Tra le Righe di Viale Gorizia, 29 Roma. Il corso è tenuto da Gianni Sarro. Per info rivolgersi a Gabriele Caramanica tel.06/87602445
Il 15 marzo avrà inizio il Corso di cinema: Visioni urbane: Roma, presso la Libreria Tra le Righe di Viale Gorizia, 29 Roma. Il corso è tenuto da Gianni Sarro. Per info rivolgersi a Gabriele Caramanica tel.06/87602445


 . Il regista è al suo quarto film, il più noto è The Kindergarten Teacher del 2014, che parla di un bambino di 5 anni che possiede un talento speciale per la poesia.
. Il regista è al suo quarto film, il più noto è The Kindergarten Teacher del 2014, che parla di un bambino di 5 anni che possiede un talento speciale per la poesia.
